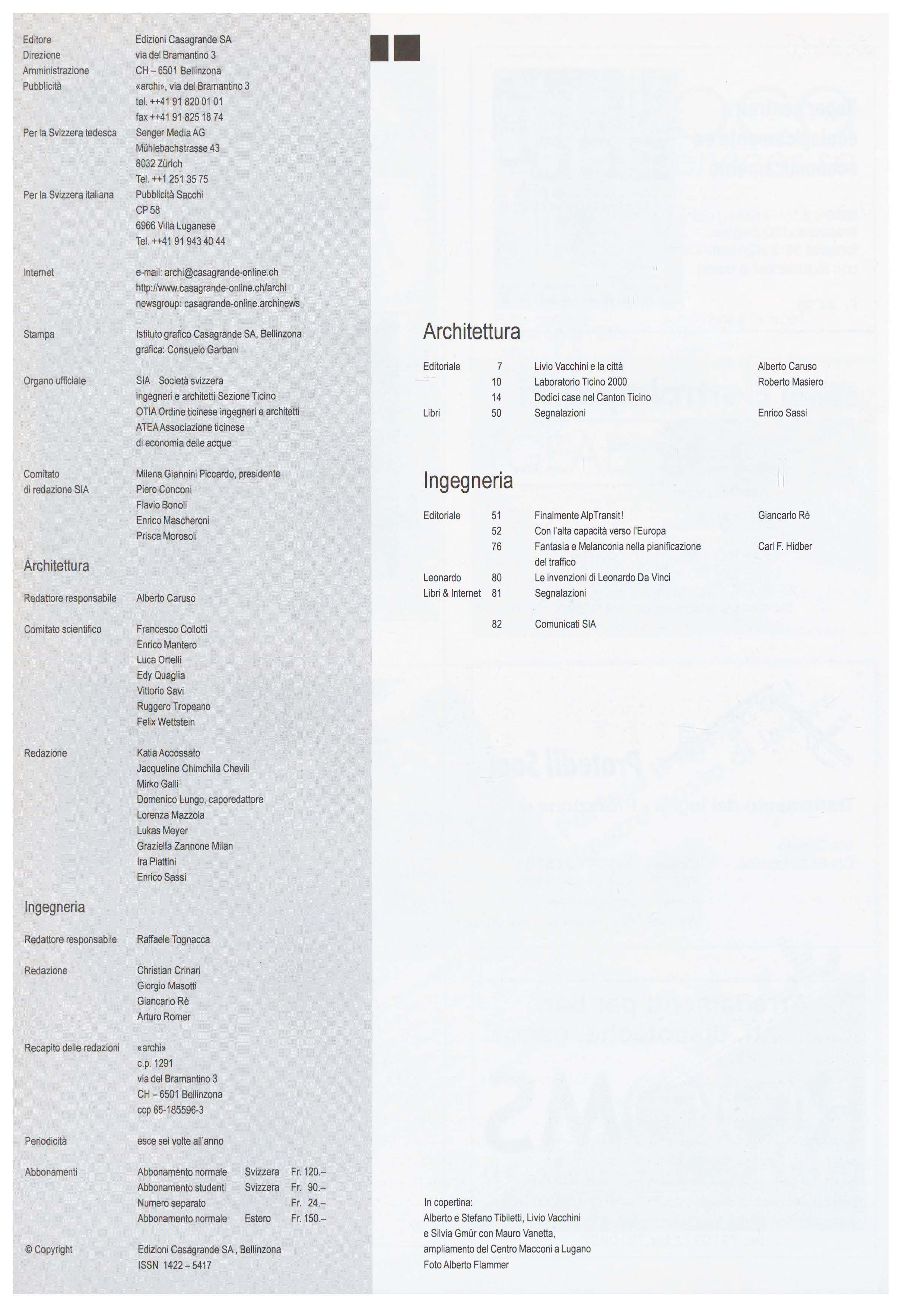Laboratorio Ticino 2000
Serie: I 20 anni di Archi (1998-2018)
Per i 20 anni di Archi, l'articolo di Roberto Masiero dal no. 5/2000. «…per una architettura che non si ponga come obiettivo quello di "rappresentare" le contraddizioni del nostro tempo, ma di provare a risolvere di volta in volta ogni singolo problema che l’architettura stessa si pone».
Sono passati tre anni da quando è stata presentata la mostra sull’architettura del Ticino, e due dalla pubblicazione Skira, L’architettura del Ticino, 1966-1996, ambedue organizzate con grande passione e rigore da Stefano Azzolin e Massimo Muttin, con la mia direzione scientifica. Sento il bisogno di riprendere alcuni schemi interpretativi, visto che il Laboratorio Ticino (intitolai così il saggio di apertura del volume Skira) è ancora vitale e carico di stimoli e prospettive, anche se frustrato dalla mancanza di incarichi professionali.
Innanzi tutto dobbiamo chiederci (o richiederci) perché dagli anni settanta in poi si viene a costituire la fama dell’architettura ticinese. Fama più che meritata e non certo dovuta alle strategie comunicative e alle sapienti «definizioni» della critica. Se la definizione coniata da Frampton, Regionalismo critico, è servita a connotare il fenomeno, e quindi a veicolarlo attraverso i mass media (che hanno sempre bisogno di slogan), non dà però conto della diversità delle figure che hanno operato e operano all’interno della produzione architettonica ticinese, né, a mio avviso, della specificità del fenomeno stesso.
Penso che il terreno di coltura del caso Ticino sia stato alimentato:
- dall’opera di Rino Tami e dalla sua rielaborazione paesaggistico-brutalista del linguaggio razionalista, con i suoi progetti per l’autostrada ticinese
- dall’opera di Peppo Brivio, con la sua adesione al linguaggio wrightiano; (grazie a Tami e a Brivio si ritrovano compresenti in Ticino le tendenze che Zevi - lo Zevi molto letto in quegli anni in Ticino - voleva assolutamente contrapporre: razionalismo e organicismo)
- dalla ricaduta in ambiente ticinese delle lezioni zurighesi di Aldo Rossi che informeranno le ragioni del «contestualismo», con Reichlin e Reinhart
- dallo straordinario lavoro di Botta teso a «sprovincializzare» la cultura ticinese e dalla sua capacità di produrre un’architettura di grande «personalità», perfettamente identificabile anche da un pubblico digiuno di critica architettonica; un’architettura capace di metabolizzare tendenze separate e persino conflittuali: Le Corbusier piuttosto che Scarpa, Kahn piuttosto che Rossi.
A questo repertorio di concause aggiungerei una ulteriore questione, di natura sociopolitica.
Nel secondo dopoguerra tutti i paesi europei erano stati costretti a rivedere il proprio linguaggio architettonico. La Germania e l’Italia, che avevano perso la guerra, non potevano mantenere una «fisiognomica» storicistico-imperialista nella loro architettura (il linguaggio classicheggiante filo greco o filo romano). D’altra parte non potevano nemmeno assumere il linguaggio dei «vincitori» che tendeva ad imporre uno stile internazionalista su matrici prettamente razionaliste. Dovevano ricostruire un’identità e la Germania la cercherà nella mediazione tra neues bauen e contestualità, mentre l’Italia la cercherà nell’estetica neorealista, costruita attorno ai linguaggi vernacolari, alle poetiche della memoria e dell’appartenenza, alle sociologie del buon vicinato.
Ambedue non potevano che elaborare una distanza dal linguaggio della Modernità. Non potevano che avere paura di ciò che si presentava come rigorosamente «Moderno», non potevano che rifiutare tutto ciò che aveva la forza o la volontà di «imporsi» come universale. Dovevano, per ricostruire un’identità, ritrovare il «locale» e «lo specifico» o un’universalità di tipo naturalistico e contestualistico. In Italia peraltro, ci fu anche una tarda, e per molti aspetti improvvisa, recezione dell’architettura di Wright, offerta al pubblico come per sua stessa natura democratica e non conflittuale con la natura e con i luoghi; organica, e quindi consolatoriamente non contradditoria oltre che portatrice di un sogno individualista e consumista, il «sogno americano».
In Francia la critica al così detto Movimento Moderno passa attraverso gli stessi eroi di quel mito, in particolare attraverso Le Corbusier che mettendo in discussione se stesso si rigenererà. In Inghilterra il Movimento Moderno viene criticato attraverso l’Indipendent Group e il New Brutalism.
In sintesi, per un motivo o per l’altro, tutti i paesi europei usciti dalla seconda guerra mondiale tendono a prendere le distanze, spesso a negare, il linguaggio razionalista, non in quanto temporalmente consumato, ma per ragioni ideologiche. Questo non accade in Ticino.
Il Ticino si ritrova, in questo frangente, in una duplice condizione:
- viene coinvolto nella riorganizzazione geopolitica dell’asse Nord Sud dell’Europa con conseguente riorganizzazione delle infrastrutture e uscita da una condizione di marginalità socio economica; nel contempo partecipa del boom economico italiano degli anni sessanta, esito del piano Marshall, con il conseguente sviluppo della domanda di architettura, sia pubblica che privata.
- a questa domanda rispondono i giovani architetti di allora, con una grande voglia di riscatto rispetto alla emarginazione geopolitica vissuta dalle generazioni precedenti.
Questi giovani sono culturalmente disinibiti, non hanno sensi di appartenenza o di colpa, non hanno «scuole» da rispettare o «padri» da uccidere. Non c’era tradizione se non quella vernacolare. Non c’era alcuna ragione ideologica per recuperarla (cosa che invece avviene in Italia). Così come non c’era nessuna ragione di legittimarsi attraverso la mitologia del Ticino patria di grandi costruttori del passato, dai Comacini, a Borromini, al Nobile. Si sa, anche la storia tende a vivere di mitologie. Volevano essere moderni, mentre, nel resto dell’Europa, tutti si interrogavano se ci fossero dei pericoli nell’essere moderni, o in che cosa aveva sbagliato quella Modernità alla quale tutti, in un modo o nell’altro, avevano creduto tra le due guerre.
La loro «verginità» o «ingenuità» permise loro di non avere debiti da pagare o crediti da richiedere al così detto Movimento Moderno. Lo «digerirono» con una sorprendente facilità, ognuno con modalità diverse. Con grande libertà non si preoccuparono né di negarlo, né di farne una scuola, semplicemente lo metabolizzarono con tutte le sue potenzialità, in tutta la sua ricchezza. Non per ragioni intellettualistiche, ma nelle «urgenze» del costruire, e della professionalità. Quella libertà, che rischiava di portarli verso un ipermanierismo modernista o postmodernista, nel migliore dei casi verso un giocoso eclettismo, diventa invece, nell’urgenza del mettere in opera, rigore nel rapporto tra ideazione, ambientazione, progettazione e costruzione.
Quali architetti e quali opere, inizialmente?
Galfetti, attento a Le Corbusier, con casa Rotalinti (1959), Snozzi e Vacchini che rielaborano Jacobsen e Mies con la palazzina Fabrizia (1964), Botta che metabolizza L. Kahn e C. Scarpa, con la casa a Stabio (1965).
Da allora abbiamo una continua produzione di opere di notevole qualità, il diffondersi della fama di Botta, e una lenta maturazione di Vacchini, dopo la separazione da Snozzi.
Diversi, indubbiamente, ma tutti con una profonda attenzione alle relazioni che si vengono a creare tra costruzione e contesto. D’altra parte avvertivano che la loro generazione si stava assumendo il compito di dare una nuova identità al Ticino in un momento cruciale del suo inserimento in un quadro culturale ed economico. Galfetti e Snozzi attenti a derivare le «disposizioni» degli assi «compositivi» dalle preesistenze naturali quanto artificiali all’interno di un linguaggio lecorbuseriano; Botta e Vacchini, pur nella loro notevole differenza, più eclettici nei riferimenti e certamente individualisti nel porre l’opera come un unicum nel territorio, come un «magnete» di qualità formali quanto costruttive.
Diversi, indubbiamente, ma decisamente tutti per la modernità. In loro non c’è alcuna nostalgia, nessun passatismo, nessuna paura rispetto al futuro - anzi c’è sempre una grande voglia di comandarlo, e quindi un atteggiamento positivo e mai idolatrico nei confronti della tecnica. In questo sono innanzi tutto costruttori e antiaccademici.
Questa generazione ha svolto la sua missione con grandissima generosità e con notevoli risultati. Non era mai accaduto nella storia dell’Università europea (e forse nemmeno mondiale) che fossero dei professionisti a fondare una Facoltà di Architettura. Questo si deve innanzi tutto a Botta e a Galfetti. Ma a loro si deve anche il fatto che essa non sia organizzata come legittimazione di una «maniera», ma come un modo per continuare nella propria libertà intellettuale ed etica.
Nel frattempo Snozzi ha realizzato uno degli esperimenti più significativi e provocatori di intervento urbano che siano stati realizzati in Europa, Monte Carasso. Se le sue architetture continuano il confronto con le opere di Le Corbusier, Monte Carasso
come work in progress sembra essere la negazione più radicale dell’«imperalismo etico della Modernità» rappresentato dalla Carta di Atene. Ciò dimostra che nei confronti dei maestri è possibile non avere un atteggiamento idolatrico o di totale rifiuto, ed è quindi possibile una tradizione del Moderno. Questo forse è l’aspetto più significativo, dal punto di vita storico-critico, delle vicende del Ticino.
Non posso nascondere la mia convinzione che il momento più problematico e vitale dell’architettura ticinese oggi, stia nelle ultime opere di Vacchini e nella sua stessa «solitudine».
Mentre Botta ha raggiunto la sua maturità come architetto (peraltro molto in fretta) grazie ad un linguaggio capace di rendere evidente la sua stessa sintassi, sino a diventare strumento altamente retorico, cioè convincente (da ciò anche la sua «fortuna»), Vacchini ha provato una progressiva spoliazione di ogni retorica arrivando ad una radicale e inedita identificazione tra architettura e struttura. Dicevo inedita. Sarebbe più giusto dire sempre presente nell’architettura occidentale, ma mai resa esplicitamente «forma».
Mentre Botta ha metabolizzato i maestri del Novecento rielaborandone la stessa capacità seduttiva; Vacchini li ha spogliati di ogni dato anagrafico o biografico per ricondurli alle stesse logiche primarie dell’architettura: come prende posizione, cioè come si appoggia al terreno; come diventa corpo, massa, figura; come incontra il cielo trovando così l’ordine archetipale, quell’ordine che precede ogni stile. In questo Vacchini si è anche liberato da ogni tirannia della funzione e di ogni estetismo intellettualista. È come se Botta avesse giocato tutte le sue carte all’interno della storia dell’architettura (senza mai cadere in qualche neostoricismo citazionista) e Vacchini avesse provato l’«oltre» ogni possibile storia. È come se Botta volesse far diventare la sua opera «storia», mentre Vacchini prova a porsi alle soglie del «senza tempo», là dove ciò che si impone - proprio in quanto si impone oggettivamente e non soggettivamente - libera il possibile, crea il superamento. La generazione di cui sto scrivendo ha creato un clima positivo che ha portato ad una coscienza del ruolo sociale dell’architettura e dell’architetto. Questo clima ha fatto nascere nuove figure di professionisti e molte ricerche attorno ai molti significati dell’architettura. Ricerche che hanno portato anche su territori un po’ paludosi. Mi riferisco all’esperienza per così dire Transmetafisica più che Postmoderna di Reichlin e Reinhart o a quella di Ortelli tesa a coniugare rossianamente storia e progetto e a riflettere attorno alla «maniera» come teoria dell’architettura. Ricerche che nella maggior parte dei casi - questo stesso numero di questa rivista ne è testimonianza - si muovono ancora nell’alveo scavato dalla generazione della quale abbiamo cercato di tracciare un breve profilo in queste pagine. Mi riferisco, tra gli altri, a Michele Arnaboldi, Roberto Briccola, Raffaele Cavadini, Mario Ferrari, Michele Gaggetta, Renato Maginetti, Stefano Moor, Orlando Pampuri, Michele e Giorgio Tognola (tralascio, in questa occasione, il fatto che alcuni di questi architetti lavorano assieme e la differenza di età).
Quali i caratteri? Grande attenzione alla localizzazione e alle relazioni contestuali, semplicità distributiva, attenzione a segnalare la distinzione tra spazio servente e spazio servito, l’utilizzo prevalente del beton, attenzione ai ritmi determinati dalle strutture o dai sistemi costruttivi, rifiuto di ogni formalismo o di ogni estetica della decorazione o di ogni retorica «dei messaggi», dell’architettura intesa come costruzione di metafore o di choc percettivi.
Forse i riferimenti sono più a Galfetti e a Snozzi, che a Botta o a Vacchini, anche se in questo numero c’è una sorta di «sigillo»: il Macconi 2 (firmato da Alberto e Stefano Tibiletti e da Livio Vacchini e Silvia Gmùr) che segnala di fatto che il lento «viaggio» di Vacchini (e dei professionisti che gli sono compagni di viaggio) porta a nuovi e imprevisti territori.
La riflessione futura dovrà, credo, trasformare tutto questo in patrimonio (e non in maniera) sapendo che le due potenti «singolarità» quella di Botta e quella di Vacchini, così diverse tra loro e così egualmente nobili, possono avere ricadute diverse nella cultura architettonica ticinese, la prima così suadente, disponibile, accattivante, persino seduttiva, tende ad una alta capacità retorica, la seconda scostante, persino indisponente, porta a identificare architettura e statica, teoria e costruzione, semplicità e oggettivazione della bellezza.
Per un osservatore esterno (tale mi considero) la cultura architettonica ticinese si trova oggi di fronte ad alcuni rischi:
- il rischio che il patrimonio prodotto sino ad oggi diventi una maniera;
- il rischio di una caduta della tensione etico professionale che ha innervato le pratiche (e le relazioni interpersonali) tra gli architetti negli anni settanta e ottanta;
- il rischio di non governare più i meccanismi relativi all’attribuzione degli incarichi e della selezione attraverso concorsi;
- il rischio di perdere, come categoria, il controllo relativo ai rapporti con la committenza pubblica e privata e quindi di perdere il controllo sulla qualità;
- il rischio di trovarsi costretti a contrattare con una speculazione edilizia sempre più determinata;
- il rischio di farsi catturare da vecchie e nuove sirene, in particolare quelle generate dal mondo zurighese con la sua attenzione concettualista ai materiali e alle tecnologie costruttive (mai risolte nel gergo High Tech), con il suo sapiente cosmopolitismo, o dalla raffinata cultura architettonica basilese o dei grigioni (inutile citare Herzog e de Meuron, Diener e Diener o Zumthor).
La speranza è che l’architettura del Ticino continui in una visione dell’architettura come costruzione del mondo e non come decorazione del mondo; per una architettura che valuti la tecnica non secondo il principio della novità, ma secondo quello della semplicità e della logica costruttiva; per una architettura in rapporto non accondiscendente con l’ambiente, artificiale quanto naturale, capace di produrre identità (cioè qualità) e non mimesi o leziose contestualizzazioni; per una architettura che non abbia bisogno della storia per giustificarsi e che nel contempo sappia imparare da tutto ciò che la storia ha elaborato; per una architettura ancorata alla professionalità intesa come scelta di rigore etico e non come opportunismo; per una architettura che non si ponga come obiettivo quello di «rappresentare» le contraddizioni del nostro tempo, ma di provare a risolvere di volta in volta ogni singolo problema che l’architettura stessa si pone. Peraltro questo è l’unico modo per rispondere al dettato implicito all’ultima Biennale d’architettura: Più etica, meno estetica, che purtroppo lo stesso curatore, in fase espositiva ha trasformato (involontariamente?) in: Più estetica e meno etica.
I venti anni di Archi (1998-2018)
Per festeggiare il ventennale della rivista Archi, una selezione degli articoli più significativi è andata a costituire una timeline, tracciando una linea di continuità tra il 1998 e il 2018. Tutti gli articoli sono contenuti nel dossier «I venti anni di Archi (1998-2018)».